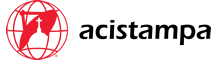Karaganda , venerdì, 20. ottobre, 2017 18:00 (ACI Stampa).
Una croce commemorativa a Karaganda, per commemorare la deportazione del popolo ucraino nella famosa “città lager”. E una lettera dell’arcivescovo maggiore Sviatoslav Shevchuk, a ricordare il modo in cui la Chiesa greco cattolica sopravvisse in diaspora, dopo il suo dissolvimento a seguito dello pseudo sinodo di Lviv del 1946.
Scuola, famiglia e Chiesa sono i tre pilastri su cui il popolo ucraino in diaspora ha mantenuto la sua identità, ricorda l’arcivescovo maggiore Shevchuk. La lettera che scrive è inviata appunto ai discendenti di quanti furono deportati in Kazakhstan dal regime comunista, l’ultima delle varie deportazioni cui il popolo ucraino fu soggetto in quegli anni – e nessuno dimentica l’holodomor di soli dieci anni prima, che alcuni hanno definito “un vero e proprio genocidio”.
Ma perché Karaganda? Perché quella città era al centro del Karlag (il Karaganda Lager), un sistema di campi di concentramento che si estendeva per 300 chilometri in un senso 200 nell’altro, includendo 26 lager. E lì, nel mezzo alla steppa centroasiatica, finirono circa in milione e mezzo di traditori della patria, come venivano definiti dai bolscevichi, vale a dire persone provenienti da 100 etnie diverse. E tra questi, migliaia di polacchi, tedeschi ed ucraini, uccisi, se non dalle temperature inumane, a causa di esecuzioni sommarie e torture. Erano soprattutto cattolici, quelli destinati a Karlag. E la Chiesa Greco Cattolica, dopo lo pseudo sinodo di Lviv, era un bersaglio quanto la Chiesa latina. Non c’è da dimenticare che a Karganda fu martirizzato il sacerdote Alexij Saritski, che San Giovanni Paolo II beatificò nel 2001.
Ricorda l’arcivescovo maggiore Shevchuk che “dopo la seconda guerra mondiale e la vittoria sul nazismo gli ucraini continuarono la loro lotta iniqua contro l'occupazione bolscevica. In una sola settimana di ottobre del 1947 lasciarono le loro case più di 77 mila ucraini, deportati sotto scorta all’Est nei gelati carri bestiame”.
L’arcivescovo maggiore sottolinea che "perfino lontano dalla propria casa gli ucraini non volevano trasformarsi in un" nuovo popolo sovietico”, persone senza propria lingua, storia e cultura. Nonostante i divieti e le repressioni, nei rifugi si sentiva la lingua ucraina, venivano osservate le feste popolari e si celebravano matrimoni ucraini. E non appena furono liberati i primi preti greco-cattolici, i piccoli, stretti rifugi si trasformarono nelle chiese clandestine".