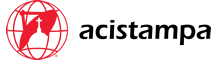Roma , venerdì, 28. marzo, 2025 18:00 (ACI Stampa).
L’orizzonte è quello affuocato degli Stati del Sud, quello dei sentieri polverosi e delle grandi ville con la bouganville gonfia di fiori, quella che ancora guarda di traverso gli yankee chiassosi e ricchi, un mondo che sembra immobile e che invece pullula di vita, spesso violenta, urlante di dolore, persino spietata, ma che guarda verso il cielo. E’ l’orizzonte dei racconti e dei romanzi di Flannery O’Connor, una delle migliori scrittrici americane del Dopoguerra. Nasce il 25 marzo 1925 a Savannah, in Georgia, da una famiglia cattolica di origini irlandesi e muore a soli 39 anni, a causa del lupus eritematoso, malattia degenerativa ereditata dal padre. Lascia due romanzi (La saggezza nel sangue, Il cielo è dei violenti) e diversi racconti pubblicati in due raccolte che possono essere davvero considerati perfetti, nella forma di scrittura e nel mettere in scena personaggi, descrizioni, soprattutto folgorazioni. Folgorazioni come quella del momento in cui la realtà si spalanca al mistero, che irrompe inatteso e imprevedibile, implacabilmente incalzante. Chi legge non riesce a capire, fino all’ultimo, come andrà la storia.
"La mente che sa capire la buona narrativa non è di necessità quella istruita, ma la mente sempre disposta ad approfondire il proprio senso del mistero attraverso il contatto con la realtà, e il proprio senso della realtà attraverso il contatto del mistero", scrive nel saggio Natura e scopo della narrativa. In cui, una volta di più, si conferma la natura ironica e insieme tragica della sua scrittura. senza alcuna ombra di moralismo. Per lei, l’uomo si trova sempre dinanzi all’eterna scelta se accettare o rifiutare l’incontro con la possibilità che il senso ultimo della vita si sveli. Che per la O’Connor è l’avvenimento dell’Incarnazione.
In una lettera che la O’Connor inviò a una sconosciuta signora di Atlanta che le aveva scritto, nel luglio 1955, ci sono, in sintesi, temi, idee convinzioni, suggestioni che, come correnti sotterranee, pervadono la scrittura dell’autrice e delineano un atteggiamento realmente, profondamente controcorrente:
“Scrivo come scrivo perché sono cattolica e non sebbene sia cattolica; questo è un fatto che niente potrà mai oscurare così come niente potrà mai oscurare un’affermazione così schietta. Tuttavia, sono una cattolica particolarmente posseduta dalla coscienza moderna che Jung descrive come astorica, solitaria e colpevole; possedere tale coscienza all’interno della Chiesa è un po’ come portare un peso, il peso necessario per il cattolico consapevole; è, cioè, avere un sentimento della situazione contemporanea al suo ultimo stadio”.
Proprio a questo punto vale la pena di aprire una riflessione che ci porti su un campo diverso. Non si discute la potenza e l’originalità della scrittrice, anche che si tratta di una lettura facile, né tantomeno consolatoria, o edificante, intenti del tutto estranei all’autrice. Ma qui il punto è un altro, qui c’è una visione chiara, anzi si potrebbe dire chiaroveggente, sul futuro prossimo venturo, quello che stiamo vivendo oggi: “ Io credo che la Chiesa sia l’unica cosa capace di rendere sopportabile il mondo cattivo verso cui ci stiamo dirigendo e che l’unica cosa che renda sopportabile la Chiesa è il fatto che essa sia, in un certo modo, il corpo di Cristo di cui noi tutti ci nutriamo. Sembra inevitabile il fatto che si abbia da soffrire tanto a causa della Chiesa quanto per essa, ma se si crede nella divinità di Cristo si deve cercare di aver caro il mondo nello stesso tempo in cui si lotta per sopportarlo. Questo spiega la mancanza di amarezza nelle mie storie”. Si lamenta poi del fatto che ogni volta che vengono recensiti suoi racconti si parla di storie brutali e sarcastiche: “Le storie sono forti, è vero, ma sono forti perché non c’è niente di più forte o meno sentimentale del realismo cristiano”, dichiara.