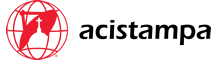Città del Vaticano , sabato, 18. aprile, 2020 12:30 (ACI Stampa).
Nell’ambito delle misure adottate dal Governo per far fronte alla situazione d’emergenza causata dal Covid-19, le riflessioni che seguiranno saranno incentrate, esclusivamente, su un tema che pare non essere stato ancora trattato adeguatamente e sul quale, date le notevoli implicazioni, si sarebbe dovuto riflettere con maggiore cura: quello dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa.
In particolare, a chi scrive sembra che questo argomento possa essere affrontato seguendo tre linee direttive: quella storica, andando a ricercare nel passato validi precedenti che possano giustificare, almeno parzialmente, le misure adottate; quella giuridica, andando a verificare il fondamento normativo delle restrizioni imposte e l’effettiva sussistenza del potere di disporle; infine, quella teologica, tenendo in debito conto l’ordine tra i fini delle due societates (i.e. il bene comune e la salvezza delle anime). Qui si seguirà la seconda via.
Nell’ambito dell’ordinamento italiano è noto che il principio della gerarchia delle fonti del diritto vede al vertice del sistema la Costituzione repubblicana che, quale atto positivo fondamentale, costituisce il referente ultimo (o primo, a seconda dell’angolo visuale prescelto) di ogni altra fonte e, al contempo, la misura dell’esercizio del potere legittimo. Ebbene, il poco spazio impone di non considerare, in via formale e generale, il problema della legittimità della lunga catena di atti normativi adottata per far fronte all’emergenza, sulla quale voci assolutamente più autorevoli e competenti si sono già espresse in modo favorevole. Ci si chiede, invece, se la singola misura della limitazione della libertà di culto, di per sé prevista in un atto senza dubbio formalmente legittimo, sia tale anche dal punto di vista sostanziale, vale a dire se lo Stato italiano ha il potere, nei confronti della Chiesa cattolica, di sospendere con un atto avente forza di legge (trattandosi, nella specie, di più decreti legge, in ragione della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 77 Cost.) le “riunioni” (sic!) di carattere religioso (art. 1, lett. c), d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, conv. con mod. in l. 5 marzo 2020, n. 13) e, più nello specifico, le cerimonie civili e religiose, limitando altresì l'ingresso nei luoghi destinati al culto (art. 1, co. 2, lett. h), d.l. 25 marzo 2020, n. 19).
A tale proposito, è chiaro che la finalità ultima della restrizione sia rintracciabile nel contenimento della propagazione del virus tra la popolazione, evitando le occasioni di stretto contatto tra le persone. Per valutare oggettivamente la scelta di sospendere radicalmente le cerimonie religiose pubbliche, chi scrive suggerisce di fare riferimento al principio di proporzionalità, limite cui deve considerarsi soggetta ogni forma d’esercizio del potere, sia esso di carattere strettamente amministrativo, sia esso di carattere normativo (tant’è che la “lente” della proporzionalità è oggi impiegata, nel nostro ordinamento, sia dal Giudice amministrativo che dalla Corte costituzionale, seppure per quest’ultima la proporzionalità costituisca sempre espressione del più generale canone della ragionevolezza e non sia, quindi, un giudizio a sé, scandito dalla stretta sequenza di controlli successivi dei quali si dirà). Ora, è noto che il giudizio di proporzionalità è tradizionalmente scandito in tre fasi: (i) la valutazione dell’idoneità dei mezzi prescelti rispetto al fine da perseguire; (ii) la verifica intorno alla necessarietà del mezzo adottato, che deve imporre il minor sacrificio possibile degli altri diritti o interessi protetti; (iii) la proporzionalità in senso stretto, che guarda agli effetti dell’atto, secondo uno schema di costi-benefici, non dovendo gravare in modo eccessivo sul destinatario della misura. Si tratta, a ben vedere, di un’analisi sul quomodo del potere.
Ebbene, se è possibile considerare superata la prima fase, in quanto è certo che la sospensione, così come disposta, valga a contenere il contagio, serie perplessità sorgono rispetto agli altri due momenti del giudizio: infatti, l’esigenza di assicurare il minor sacrificio possibile degli altri diritti costituzionalmente tutelati avrebbe dovuto richiedere delle misure che tenessero conto del fatto che il diritto fondamentale, previsto dall’art. 19 Cost., di professare liberamente la propria fede, esercitandone pubblicamente il culto, trova un unico limite: il buon costume. È vero che, sul piano costituzionale, nella situazione d’emergenza nella quale ci troviamo, questo diritto verrebbe a essere bilanciato con la salute quale interesse della collettività (art. 32 Cost.) e con i limiti alla libertà di circolazione che l’art. 16 Cost. prevede per motivi di sanità o sicurezza, tuttavia resta la positiva previsione che il culto pubblico non può essere di per sé impedito, né sospeso per motivi diversi dal buon costume. In sintesi, una misura proporzionata, che tenesse conto di questi delicati rapporti tra norme costituzionali, avrebbe imposto una soluzione differente: in particolare, l’assistenza del popolo alla celebrazione della santa Messa, presso la chiesa più vicina alla propria abitazione o comunque presso la parrocchia di afferenza, secondo modalità atte a garantire il rispetto delle distanze minime, l’igiene dei luoghi e il contingentamento dei fedeli all’ingresso, vale a dire le medesime misure pensate e attuate per consentire la spesa ai supermercati. D’altronde, sono proprio queste le misure richieste dall’art. 2, lett. v), D.P.C.M. 8 marzo 2020 come condizione per la generale apertura dei luoghi di culto, ma è evidente l’irragionevolezza se ciò si traduce nell’impossibilità di assistere al culto. Ben si comprende, quindi, che l’interpretazione corretta della norma avrebbe imposto di non considerare la santa Messa tra «le cerimonie civili e religiose […]», essendo essa il culto e non una semplice cerimonia, come possono esserlo i funerali e i matrimoni. Quanto scritto fin qui riguarda, come detto, il quomodo.