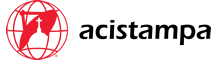Roma , lunedì, 14. aprile, 2025 14:00 (ACI Stampa).
Inziata ufficialmente la Settimana Santa, fulcro dell'anno liturgico. Non è un caso, infatti, che la Settimana Santa viene detta anche “Settimana maggiore” (in latino, “Hebdomada maior”). Una Settimana che vede ripercorrere la Passione di Cristo: dalla celebrazione di ieri, quella delle Palme, che vede l'entrata di Gesù a Gerusalemme fino al clou della settimana, il cosiddetto “triduo pasquale”.
In origine il Lunedì Santo non era giornata stazionale, dunque nemmeno liturgica. Così come il Martedì. In questo giorno, poi, venne istituita la stazione nella chiesa di Santa Prisca sull'Aventino. Il Mercoledì Santo - quando la stazione era aliturgica - il clero assieme al popolo si radunavano di mattina al Laterano. Qui si spiegava la Passione. Una volta che venne introdotta la liturgia stazionale, il raduno avveniva a San Pietro in Vincoli: da qui si muoveva una processione verso la basilica di Santa Maria Maggiore.
E, veniamo, al Triduo pasquale. Si inizia con il Giovedì Santo, con la mattinata dedicata alla benedizione degli oli santi. Ciò avviene a San Giovanni in Laterano. Alla sera, ecco una delle liturgie più importanti: quella commemorativa dell'istituzione dell'Eucaristia. Durante la Santa Messa vengono consacrate due ostie: una di queste dovrà servire per il giorno seguente in cui non si consacra. La celebrazione si chiude con una processione dell'Eucaristia che viene deposta dentro il ciborio appositamente preparato sopra un altare. Una volta deposta l'Eucaristia, allora, si procede al ricordo della lavanda dei piedi. Due temi portanti della giornata, dunque: l'istituzione dell'Eucaristia con l'ultima cena di Cristo e il servizio.