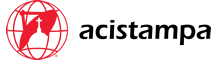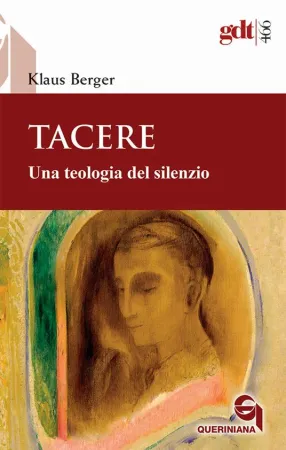Roma , venerdì, 28. febbraio, 2025 18:00 (ACI Stampa).
Il rumore del silenzio. La voce del silenzio. La musica del silenzio. Queste espressioni si sentono spesso e definiscono qualcosa che sembra una contraddizione in termini. I poeti, gli scrittori, gli artisti in generale, conoscono invece questa possibilità. Il silenzio non è semplicemente assenza di suoni, rumori, ma un ritmo interiore, una voce particolare, una risonanza che si dilata nell’anima e permea tutto di se’. Allora, allargando il campo, ci si chiede se può esistere una teologia del silenzio?
Klaus Berger, teologo, affronta questo tema, partendo da un’apparente contraddizione: il cristianesimo è una religione della parola. Ma si chiede: Dio parla veramente quando “parla”? Quanto è comprensibile il suo discorso? Egli parla anche nel silenzio, cioè quando tace? Per cercare di rispondere a queste domande, l’autore di un testo affascinante, “Una teologia del silenzio”, in cui si sviluppa dapprima una “fenomenologia del silenzio”, poi un’indagine ampia ed esauriente sul tacere: dal silenzio dei grandi testimoni biblici, a quello dei cristiani di ogni epoca; dalla quiete silente della creazione, no al silenzio della liturgia (in particolare del Sabato santo); dal silenzio dei mistici a quello ascetico, fatto di riverenza per il Mistero. Da questi passaggi Berger ricava gli elementi di una teologia del silenzio: tacendo Dio si rivela. Questo accade quando gli uomini si lasciano raggiungere dal suo silenzio, lo interpretano e lo comprendono, quando si rivolgono a lui senza troppe parole e, così, avvertono la sua volontà.
Sul silenzio, sulla sua necessità, sulla difficoltà di “viverlo”, di mettersene davvero in ascolto ha parlato spesso, e ne ha scritto, in modo mirabile, papa Benedetto XVI. Lo ha fatto in diverse occasioni e in vari contesti. Lo ha fatto, ad esempio, nel 2012, durante l’udienza generale dell’8 marzo, quando ha ricordato quanto sia prezioso in un tempo come il nostro, che non favorisce il “raccoglimento” ma anzi alimenta la “paura a staccarsi, anche per un istante, dal fiume di parole e di immagini che segnano e riempiono le giornate”.
È per questo, secondo il pontefice, che è necessario “educarci al valore del silenzio” e “riscoprire il senso del raccoglimento e della quiete interiore”: “Il silenzio – ha spiegato infatti il Papa – è capace di scavare uno spazio interiore nel profondo di noi stessi, per farvi abitare Dio, perché la sua Parola rimanga in noi, perché l’amore per Lui si radichi nella nostra mente e nel nostro cuore, e animi la nostra vita”. In questo contesto, papa Ratzinger ha richiamato l'importanza del silenzio nella liturgia che – ha spiegato – devono essere “ricche di momenti di silenzio e di accoglienza non verbale”.
Ma è possibile che anche Dio rimanga in silenzio di fronte alla preghiera dell'uomo. In quei momenti, ha commentato il papa, “proviamo quasi un senso di abbandono, ci sembra che Dio non ascolti e non risponda. Ma questo silenzio di Dio, come è avvenuto anche per Gesù, non segna la sua assenza. Il cristiano sa bene che il Signore è presente e ascolta, anche nel buio del dolore, del rifiuto e della solitudine”.
Altra occasione per riflettere sul tema, la postfazione del libro dal titolo significativo “La forza del silenzio. Contro la dittatura del rumore”, scritto dal cardinal Robert Sarah, in cui Benedetto si ricollega direttamente alla grande tradizione del silenzio che percorre l’intera storia del cristianesimo. Gesù è esemplare in questa dimensione del rimane in ascolto, nel tacere, spiega Ratzinger,” passava le notti in silenzio a colloquio con il Padre, le sue parole, i suoi discorsi venivano dal silenzio e potevano formarsi solo in quel modo. La sua parola la possiamo capire solo entrando nel suo silenzio, se impariamo dal suo silenzio”.
E c’è il silenzio del Sabato Santo, un silenzio che prima atterrisce, quasi annichilisce, ma poi quella tenebra in cui la voce non si articola più diventa un grembo in cui è custodito il grumo di luce che le squarcerà, quelle tenebre. In una meditazione che risale al 1967 ed è raccolta nel volume “Il Sabato della storia” di Joseph Ratzinger e William Congdon, edito da Jaca Book, il futuro Pontefice sviluppa questo tema, a partire dal concetto, che attraversa la modernità della “morte di Dio”.