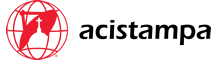Una vita attiva, dunque…
Accetto il cambiamento come una chiamata di Dio. Era bello essere lì dove Chiara Lubich, la fondatrice del nostro movimento, aveva vissuto, respirare anche con i primi compagni di Chiara, perché dieci anni fa tanti di loro erano ancora vivi. Eppure, non mi sentivo pienamente al mio posto., mi mancava l’adrenalina della vita a Gerusalemme che mi aiutava a vivere il Vangelo ogni giorno. Perché a Gerusalemme c’era la sfida di continuare a credere, di continuare a testimoniare che è possibile vivere per l’unità, nonostante tutte le difficoltà.
Cosa cambiava nel Centro Internazionale?
Non si sentivano più le ambulanze continuamente, non si vedevano i soldati per strada. Avevo, irrazionalmente, paura che la mia radicalità di vivere il Vangelo venisse meno. È in questo contesto che mi arriva la notizia dell’invocazione per la pace in Terrasanta, e che il Papa aveva invitato a partecipare i due presidenti palestinese e israeliano. Si cercava qualcuno che sapesse la lingua araba, e che potesse leggere un brano in quel momento di preghiera.
E lì ha deciso di partecipare?
In realtà, non sapevo se accettare questo invito o no. Ero in questo atteggiamento interiore che non mi lasciava in pace. Sono andata in cappella e ho chiesto a Dio cosa avrei dovuto fare. Apro le letture del giorno, e mi trovo Atti 23,10-11, dove si legge: “Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma”.
Sembrava un messaggio preciso…
Mi ha dato coraggio. Mi ha comunicato che, anche con il pensiero di essere fuori posto, avevo una opportunità di testimoniare Gesù. E così ho accettato di partecipare all’invocazione, e ho letto, in arabo, la preghiera di San Francesco, con quel suo “Dove è odio che io porti l’amore” denso di significato, in un momento molto forte, di fronte a Papa Francesco, al Patriarca Bartolomeo, a tanti israeliani, palestinesi, , inclusi capi religiosi ebrei e musulmani. Leggendo quella preghiera, portavo lì il grido della giustizia e della misericordia. Ho letto dunque quella preghieracon commozione profonda.
Dieci anni dopo, quell’invocazione avrebbe ancora senso?
Si è trattato di un momento bellissimo, anche se si sentivano le tensioni, c’è chi ha parlato a braccio, lasciando da parte il testo scritto. Io percepivo questa tensione e questi rancori. Sono tuttavia consapevole che Dio vede dall’alto il ricamo più bello, mentre noi continuiamo a vedere i nodi. Poi, dopo l’invocazione è scoppiata la guerra a Gaza, dieci anni dopo la situazione non è migliorata. Allora viene da chiedersi: questa preghiera quale frutto ha portato? È servita a qualcosa? Ma io ho davanti ai miei occhi l’albero di ulivo piantato nei giardini Vaticani, e questo per me è il simbolo di quella giornata. In effetti, per portare frutto, le radici devono andare proprio in fondo nel terreno, penetrare il fango, superare il buio, radicarsi in una realtà di dolore. Questa è la mia speranza.
Allora a che serve la preghiera?
Rispondo con le parole del Cardinale Pizzaballa, oggi Patriarca Latino di Gerusalemme, che allora era il Custode dei Francescani in Terrasanta e al quale, dopo la preghiera, a seguito dello scoppio della guerra a Gaza, fu fatta la stessa domanda. “La preghiera – disse il Patriarca - non produce. La preghiera genera. Non sostituisce l’opera dell’uomo, ma la illumina. Non esonera dal percorso ma lo indica. E in questo senso, l’incontro di Roma è stato e rimane un segno potente e forte, vincolante. E’ l’immagine alla quale richiamarsi e che dà speranza a chi non si rassegna alla triste realtà dei nostri giorni”. Faccio mie queste parole, e so che dobbiamo continuare non solo a pregare, ma a lavorare per la pace, ad educare alla pace.
Iscriviti alla nostra newsletter quotidiana
Ricevi ogni giorno le notizie sulla Chiesa nel mondo via email.
Nell'ambito di questo servizio gratuito, potrete ricevere occasionalmente delle nostre offerte da parte di EWTN News ed EWTN. Non commercializzeremo ne affitteremo le vostre informazioni a terzi e potrete disiscrivervi in qualsiasi momento.
Il grande tema, nel conflitto in Terrasanta, ma anche nei conflitti del mondo, è quello della riconciliazione. Come vivere come fratelli dopo che si è vissuta la morte e la distruzione causata dall’uno o dall’altro? Il perdono, tra l’altro, è un tema cristiano. Lei, nei suoi anni in Terrasanta, ha visto atti di perdono che possono lasciare una speranza?
Direi che è meglio parlare di riconciliazione più che di perdono. Perdono è una parola molto forte, e sono pochi quelli che riescono a perdonare, a sentirsi liberi con la sensazione di aver avuto una giustizia, sociale, umana e politica. Ma, tornando alla domanda, sì, ho visto tanti atti di riconciliazione, situazioni molto forti.
Ci fa qualche esempio?
Per esempio, in Terrasanta si è sviluppata l’associazione Parents Circle, il circolo dei genitori. È una associazione che riunisce israeliani e palestinesi che hanno un parente ucciso durante i conflitti. Questi genitori – è una associazione di circa 600 persone – lavorano su percorsi di riconciliazione. Fanno incontri, guardando l’altro non come un nemico ma come qualcuno che possa educare alla pace. E poi, vanno insieme a raccontare la loro storia. Sono storie di grande impatto emotivo, che loro condividono incontrandosi anche per riconciliarsi e portare una mentalità diversa, arrivando ad una strada di dialogo e di pace.
È successo qualcosa che la ha coinvolta personalmente?
Quando abitavo a Gerusalemme, una nostra vicina ha invitato alcune di noi del focolare a casa sua. Non sapeva che ero araba, neppure che sono una cristiana. Quando lo ha capito, mi ha detto: “non ho mai ricevuto un arabo a casa mia”. Io ero con altre focolarine e in quel momento ho pensato che me ne sarei dovuta andare. Poi ho compreso che dovevo essere pronta a fare un passo interiore e a non prendere la sua frase come una offesa a tutto il mio popolo, perché è facile entrare nella trappola di pensare che una frase del genere significa sminuire, o peggio attaccare, tutto ciò in cui credi. Allora, ho cominciato invece a dialogare con lei, a raccontarle che avevo studiato l’ebraismo e la cultura ebraica, che credevo nella pace. E ho visto questa donna, un passo alla volta, abbandonare le sue difese, e comprendere che, se io la pensavo così, ci sarebbero stati altri come me che lottavano per la pace. È nata così tra noi una amicizia.