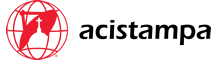Erbil , martedì, 7. aprile, 2015 14:04 (ACI Stampa).
Io, come te.” Le parole vengono fuori in dialetto curdo, ma i gesti sono inequivocabili. La bambina di circa 10 anni che risiede con la famiglia in uno dei campi allestiti dalla Caritas nei dintorni di Erbil indica la croce che porto al collo, e mi fa capire che è anche lei è cristiana. Sembra una banalità, ma qui è importante. Perché i cristiani che sono scappati da Mosul e che si sono riversati nel Kurdistan iracheno in cerca di sicurezza non si fidano più di nessuno che non sia cristiano.
“Siamo stati traditi dai nostri fratelli musulmani,” ripetono, quasi a bassa voce, ma in maniera costante. In fondo, tutti sanno che non è un problema strettamente religioso. Ma di certo non riescono a scacciare dagli occhi il momento in cui le milizie dell’autoproclamato Stato Islamico hanno preso possesso dei loro villaggi, hanno imposto la shari’a, hanno chiesto ai “nazareni” di pagare una tassa o andare via. Il tutto, mentre i loro amici musulmani sopportavano in silenzio, senza difenderli.
Sono i volti della guerra, che è un catalizzatore di paure nascoste. La religione non era un problema, ora lo è. La necessità di chiudersi in comunità omogenee non era un problema, ora lo è.
Quello che più si fa sentire è il senso di precarietà che vivono i profughi. La bambina la incontro in un campo composto da vari container, donati dalla Conferenza Episcopale Polacca e dalla sezione polacca di Aiuto alla Chiesa che Soffre. La visita è parte del programma di una visita organizzata dal Pontificio Consiglio Cor Unum dal 26 al 29 marzo, cui ha partecipato ACI Stampa. Il campo profughi è in una struttura che un tempo era un campo sportivo per i brasiliani che arrivavano ad Erbil con l’illusione degli investimenti portati dal petrolio, e sulle insegne ci sono ancora i volti di Kakà e Ronaldinho.
La città è lontana. Non c’è una fogna, e l’acqua viene fatta scorrere in un rivolo nel centro dei vialetti dei container. Una situazione che anche il Cardinal Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, ha notato. “I cristiani che ho incontrato – ha detto il Cardinale in una intervista a Radio Vaticana - soprattutto ad Erbil, erano in una situazione abbastanza penosa. Vivono, infatti, in una struttura dove purtroppo i servizi e l’ambiente non sono proprio dei migliori. Abbiamo, però, ricevuto la certezza da parte delle autorità che subito dopo Pasqua saranno tutti trasferiti in un centro, dove vi sono delle roulotte, dei container adibiti a piccole case, dove credo, sotto tutti i punti di vista, la loro dignità, la loro collocazione, il loro ambiente sarà migliore. Certo, in queste strutture ‘rimediate’ e in simili forme di convivenza, le malattie aumentano soprattutto per gli anziani. Le malattie hanno afflitto e affliggono ancora la popolazione.”