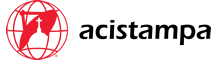Nella legge, la somministrazione di acqua e di cibo vengono, dunque, considerati come “trattamenti sanitari”, che possono essere interrotti su richiesta del paziente. Domandiamoci: quali sofferenze può patire il paziente lasciato morire di fame e di sete? Già nel 1986 una equipe di medici specialisti, su incarico di un giudice del Massachusetts (USA), che aveva autorizzato il distacco del sondino naso-gastrico da un paziente in stato vegetativo, stilò un documento che descriveva la morte per disidratazione come agonia atroce.
Per questo motivo, Giovanni Paolo II e più recentemente la Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera Samaritanus Bonus sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita (14 luglio 2020), hanno preso sulla questione una chiara posizione. La lettera, nel paragrafo che tratta de Le cure di base, riafferma che l’idratazione e l’alimentazione di un malato in stato di incoscienza senza prospettive di guarigione, rappresentano un mezzo naturale di conservazione della vita, non un atto medico e, conseguentemente, costituiscono atti dovuti di semplice accudimento della persona, un’attenzione clinica e umana primaria e ineludibile (IV, 3). Il documento definisce quindi l’obbligatorietà di una tale cura della persona, attraverso un’appropriata idratazione e nutrizione [che] può esigere in alcuni casi l’uso di una via di somministrazione artificiale, a condizione che essa non risulti dannosa per il malato o provochi sofferenze inaccettabili per il paziente (V,3).
Potranno, certamente, verificarsi circostanze in cui anche l'idratazione e l'alimentazione vanno sospese perchè si configurano come atti futili. E questo accade quando il fornire sostanze nutrienti e liquidi fisiologici non risulta di alcun giovamento al paziente, perché il suo organismo non è più in grado di assorbirli o metabolizzarli. In questo caso non si anticipa illecitamente la morte per privazione dei supporti idratativi e nutrizionali essenziali alle funzioni vitali, ma si rispetta il decorso naturale della malattia critica o terminale. In caso contrario, la privazione di questi supporti diviene un’azione ingiusta e può essere fonte di grande sofferenze per chi le patisce (cfr V,3).
Queste considerazioni ci portano a respingere l’accanimento terapeutico, il quale non è il rifiuto del paziente e della sua vita, ma rifiuto di intraprendere o decisione di interrompere una terapia sproporzionata ai fini del sostegno alla vita o del recupero della salute (cfr. Giovanni Paolo II, Discorso al PC per la Pastorale della Salute, 12 novembre 2004). La sospensione della terapia, tuttavia, non deve fare venire meno la cura della persona. Mi diceva un’infermiera che lavora in un hospice che è importante fare controllare un occhio, un orecchio, un ginocchio anche quando il malato è quasi giunto al termine della vita, perché il compito centrale di chi lavora nelle cure palliative è accompagnare ed aiutare a rimanere vivi fino alla fine, dentro ad una dignità insita nella persona umana.
2. Dal 13 dicembre sarà discussa in Parlamento la proposta di legge dal titolo «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita», già approvata, il 6 luglio 2021 da parte delle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera.
Nell’Articolo 2 si specifica che “si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo col quale [...] si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale” (Art 2). Viene inserito il concetto di “morte degnitosa”, quasi a volere significare che la vita toccata dalla sofferenza e privata di autonomia, non è più degna di essere vissuta. E questo è inaccettabile non solo per una coscienza religiosamente sensibile.
Ma davvero la vita di coloro che si trovano in gravi condizioni di salute può essere considerata meno degna rispetto alla vita di chi è in salute? Certo, di fronte alla persona che soffre è assolutamente doveroso fare tutto il possibile per lenire ogni dolore, ma possiamo davvero affermare che la dignità umana viene meno col sopraggiungere della sofferenza? Accogliere la richiesta di porre fine alla propria vita con il suicidio assistito significa dire al malato che la sua vita non ha più alcun valore, che è una vita da scartare. Papa Francesco non si stanca di ricordare come il contesto socio-culturale attuale stia progressivamente erodendo la consapevolezza riguardo a ciò che rende preziosa la vita umana. Questa erosione è dovuta al fatto che sempre più spesso la vita umana viene valutata in ragione della sua efficienza e utilità, al punto da considerare “vite scartate” o “vite indegne” quelle che non rispondono a tale criterio». (Samaritanus bonus, V, 1). La vita umana, al contrario, è sempre un bene intangibile e un valore inalienabile e, quando la persona giunge a chiedere la morte, occorre domandarsi cosa cela quel grido. Dunque porre fine alla propria vita attraverso il suicidio assistito non potrà mai essere sinonimo di morte degna.
Il 28 febbraio 2014 in Belgio è stata promulgata la legge che approva l’eutanasia per i minorenni, senza limiti di età. In un articolo apparso su un quotidiano belga un genitore ha dichiarato: “I genitori migliori sono quelli che lasciano andare i propri figli”. Ma è proprio così? Esiste una grande differenza tra lasciare andare un figlio e ucciderlo. In un’intervista il neuro-pediatra francese Alain de Broca, fondatore dell’ Associazione per la promozione delle cure palliative in pediatria, ha commentato: In tutta la mia vita non ho mai sentito un bambino che abbia chiesto di essere lasciato morire perché soffriva troppo. E ha precisato: L’eutanasia non è una cura, ma soltanto un termine per mettere fine alla vita dei malati. Di fatto in questo modo si sceglie di rinunciare a occuparci di loro. (Sussidiario. Net 4,12.2013). Se un bambino non ha mai chiesto l’eutanasia, qualcuno deve suggerire loro questa possibilità. Ma è immaginabile un mondo in cui sono i genitori a proporre ai loro figli di morire? I migliori genitori sono quelli che si prendono cura dei loro figli fino alla fine.
3. Il Papa e i Vescovi avevano invitato il Parlamento italiano a riflettere sulla possibilità di incentivare le cure palliative agli ammalati, in alternativa al suicidio assistito. In questo terzo punto vogliamo metterci in ascolto di chi ha vissuto sul campo l'esperienza della prossimità a chi soffre. Tra le personalità più autorevoli e credibili troviamo la straordinaria figura di Cicely Saunders (1918-2005), infermiera britannica, poi divenuta medico e fondatrice del primo hospice, il St. Cristopher a Londra. Questa straordinaria donna ha posto le basi della nostra moderna terapia del dolore e delle cure palliative. In particolare la Saunders intuisce che liberare la persona malata dal dolore e dalla sofferenza significa comprendere che dolore e sofferenza non hanno solo una dimensione fisica, bensì anche emotiva, psicologica, sociale e spirituale. E’ ciò che lei definisce il dolore totale, davanti al quale ci può essere solo la risposta di un amore totale che si rende presenza.
Il paziente terminale deve anzitutto continuare a vivere la relazione, come elemento costitutivo della sua natura: relazione coi suoi cari, con chi lo assiste, e, non da ultimo, deve avere la possibilità di coltivare la sua relazione con Dio. Cicely aveva scoperto che l'indicazione più preziosa per accompagnare la persona nel suo ultimo tragitto terreno è racchiusa nelle parole che Cristo nel Getsèmani dice ai suoi apostoli: Vegliate con me. L'esperienza e l'eredità lasciata da Cicely e da tanti altri come lei incarnano l’autentica solidarietà con il paziente perchè ci insegnano il vero significato della compassione, che consiste nel “prendersi cura”.
Concedere il diritto di richiedere l’eutanasia o il suicidio assistito, per garantire il rispetto dell’autonomia del singolo, o per regalargli un gesto di “pietà”- come spesso si sente dire -, o permettergli una “morte degna”, significa aprire le porte ad una cultura disumanizzante che considera il paziente soggetto un isolato e ne esaspera la solitudine perchè lo stacca da ogni relazione di aiuto. Si tratta di una visione della vita che si pone in totale antitesi al valore della solidarietà e all’esigenza del vero amore che rendono solidali con il dolore altrui e non pensano di sopprimere colui del quale non si può sopportare la sofferenza. Il gesto dell’eutanasia appare ancora più incomprensibile e perverso se viene richiesto dal coloro che – come i parenti – dovrebbero assistere con pazienza e con amore il loro congiunto o dai medici che per la loro specifica professione, dovrebbero curare il malato anche nelle condizioni terminali più penose ( cfr. Lett. enc. Evangelium vitae, 66).
Ma ora chiediamoci: un paziente che giunge a domandare la morte, in realtà che cosa sta dicendo? Non è forse il suo un grido che va interpretato? Una richiesta di aiuto che deve essere decodificata? L'esperienza della dottoressa Cicely Saunders e di molti altri, conferma che «le suppliche dei malati molto gravi, che talvolta invocano la morte, non devono essere intese come espressione di una vera volontà di eutanasia; esse infatti sono quasi sempre richieste angosciate di aiuto e di affetto. Oltre le cure mediche, ciò di cui l’ammalato ha bisogno è l’amore, il calore umano e soprannaturale, col quale possono e debbono circondarlo tutti coloro che gli sono vicini, genitori e figli, medici e infermieri». (Samaritanus bonus, V, 2). Qui non posso non rivolgere un invito a leggere o a riprendere la Lettera apostolica Savifici doloris di Giovanni Paolo II( 11 febbraio, 1984) dove il Papa aiuta a comprendere come Dio e l’uomo, divinità e umanità, senso soprannaturale e senso umano vanno insieme. Anzi, con la sua nascita nella carne Dio è venuto a dire alla sua creatura che proprio là, dove il cammino si fa più difficile, il suo braccio e quello dell’uomo sono più fortemente l’uno nell’altro.
Iscriviti alla nostra newsletter quotidiana
Ricevi ogni giorno le notizie sulla Chiesa nel mondo via email.
Nell'ambito di questo servizio gratuito, potrete ricevere occasionalmente delle nostre offerte da parte di EWTN News ed EWTN. Non commercializzeremo ne affitteremo le vostre informazioni a terzi e potrete disiscrivervi in qualsiasi momento.
Chi assiste e si prende cura del malato è chiamato a donare se stesso in termini di presenza amica, di compagnia forte e benevola, di prossimità umana. Chi ama non lascia solo (“autonomo”) il bisognoso, ma gli rimane accanto condividendo, per quanto gli è possibile, il suo dolore, sostenendo la sua debolezza. La vicinanza e la modalità di guardare la persona malata è parte della cura, creano i presupposti della dignità della persona stessa. Chi si trova amato, capito e accompagnato nell’ultimo tratto della sua vita, difficilmente giungerà a chiedere l’eutanasia, ma troverà la serenità che solo l’abbandono alle cure dell’amore può dare, diventando lui stesso dono per l’altro. La vicinanza e la competenza non si improvvisano, vanno coltivate, aiutate, formate.
CONCLUSIONE
Riflettere sul fine vita implica dunque considerare il senso autentico del dono della nostra libertà. La cultura individualista, in cui siamo immersi, ci presenta la libertà come la capacità di scegliere indifferentemente una cosa o l’altra, come possibilità di autodeterminarsi. Sono libero se non dipendo da nessuno; sono libero quando posso fare tutto quello che voglio. In realtà l’esperienza insegna che l’uomo non è un assoluto e che isolarsi e comportarsi solo secondo la propria volontà è contrario alla verità del proprio essere. Infatti, l’uomo è un essere in relazione ed entra nella verità di se stesso solo quando accetta questa sua relazionalità. Se io mi assolutizzo, divento nemico dell’altro, non posso più convivere e tutta la vita diventa crudeltà, diventa fallimento.
Applichiamo questo dato al malato. E chiediamoci: “Il malato da solo come può essere libero?”. La risposta è no, non è libero, perchè la realtà della malattia condiziona le sue scelte e per aiutarlo a compiere una scelta responsabile è fondamentale una compagnia di amici e professionisti che gli siano accanto, lo aiutino a ritrovare ogni giorno le ragioni del vivere, capaci di fargli capire il valore della sua presenza tra di noi. Per questo motivo si può parlare di una autonomia “relazionale”.
La giornalista Eugenia Roccella conclude un suo articolo, apparso sul quotidiano Avvenire del 24 novembre 2021, con queste parole: “ Mentre le terapie intensive tornano a riempirsi per il Covid si cerca di far passare la morte autoprocurata non come una scelta libera e tragica, che una comunità solidale deve cercare di evitare, ma come un diritto. Dobbiamo decidere se vogliamo un Paese dove la morte è un diritto del singolo, a cui essere indifferenti, o se l’Italia deve restare il Paese dove il Presidente della Repubblica premia la carabiniera Martina capace di passare tre ore su un ponte, accanto a una donna che aveva già scavalcato il parapetto, convincendola a non buttarsi. Questo è il Paese che amiamo”.
Per cercare di tradurre in senso esistenziale questa visone della libertà riporto la storia di due persone: rispettivamente di un uomo e di una donna, molto distanti per stile di vita, ma ambedue segnati dal dramma della sofferenza. Entrambi giovani, certamente pieni di sogni e di progetti da realizzare.