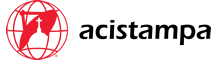Ancona , sabato, 6. giugno, 2020 14:00 (ACI Stampa).
Si chiama ‘Covid-19, empatia e dialogo come cura’ l’ultimo lavoro di Claudio Colotti, il fotoreporter maceratese, che dal 20 al 26 aprile è entrato nell’ospedale di Torrette di Ancona, capoluogo marchigiano, raccontando con i suoi 50 scatti quello che stava accadendo nei reparti dedicati a pazienti positivi al coronavirus in un lavoro d’impatto, come ha spiegato il fotoreporter: “Mi sono reso conto che nonostante tutti i sistemi di protezione usati, infermieri, dottori e fisioterapisti riescono comunque a stabilire un contatto con i pazienti, pure di tipo fisico, fatto spesso di gesti importanti. Come una carezza. Nonostante guanti, mascherine, occhiali a tenuta stagna, visiere in plexiglas, il coinvolgimento emotivo non è venuto meno. Non ci sono appigli per vedere l’altro, la comunicazione tra paziente e operatore è difficoltosa. Ma si è vicini con questi gesti”.
Come ci si sente a fotografare in un reparto covid 19?
“All’inizio è imbarazzante e doloroso. Noi fotogiornalisti abbiamo il dovere morale di giustificare la nostra presenza in un luogo dove la sofferenza può toccare punti apicali. Normalmente lo facciamo offrendo la nostra identità e le nostre intenzioni in maniera chiara, a viso scoperto. Avvicinando le persone e facendo sentir loro la nostra comunione emotiva al dramma che stanno vivendo. Con il COVID far questo è stata un’impresa titanica. Sparire dentro un’anonima tuta di protezione è stato come se mi fossi ritrovato senza la mia identità. Realizzare che infermieri e pazienti non avrebbero mai potuto vedere il mio viso e quindi le mie emozioni mi ha lasciato da subito addosso una sensazione di disagio. Mi ci è voluto del tempo per capire che in una situazione estrema come quella i nostri recettori sono spalancati al punto che i sentimenti attraversano anche la plastica ed il nylon”.
Quale impatto c’è stato ad entrare in un reparto covid 19?
“Nelle prime ore ho avuto una sensazione di e alienazione, quasi come se mi stessi muovendo in assenza di gravità. I sistemi di protezione integrale attutiscono tutti i sensi compresi la vista e l’udito. All’interno di questa cornice si è innestata la paura strisciante del possibile contagio che non mi ha mai abbandonato. Gli occhiali di protezione oltre ad appannarsi limitavano il mio campo visivo e da subito ho provato lo shock di dover gestire in maniera del tutto innaturale la mia spazialità. Per paura di poter essere d’intralcio a dottori e infermieri ho iniziato calcolare ogni singolo spostamento. E in tutto questo io dovevo comunque trovare la concentrazione per scattare”.